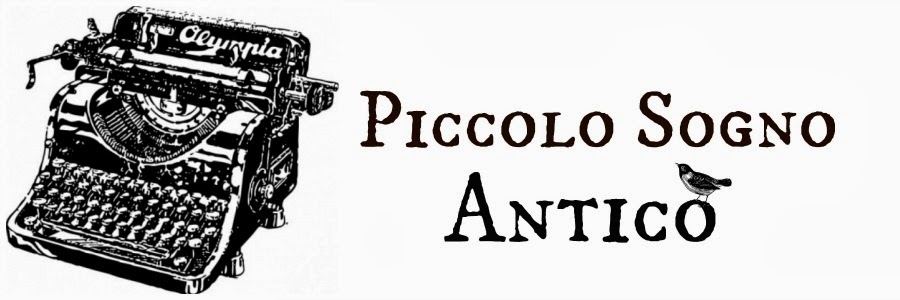Spesso si resta immobili tanto a lungo da credere che quello che vediamo sia ciò che davvero abbiamo davanti al naso. Ma non è così. Non serve molto, qualche millimetro talvolta, può cambiare un intero punto di vista.
Dobbiamo essere grati a chi ci muove. Soprattutto a chi ci muove da dentro.
Cheyenne è una rock star cinquantenne in pensione ‘forzata’ da troppi anni. Vive a Dublino negli agi di una vita che gli consente di passare nell’ozio più totale le sue giornate senza il minimo bisogno di lavorare, e se la lascia scivolare addosso senza opporre la minima resistenza.

La sua è una routine quotidiana che si ripete da anni sempre uguale: si sveglia, fa la spesa al centro commerciale, prende un caffè con un amica, torna a casa e infila nel microonde una pizza surgelata, aspettando che cuocia seduto nella monumentale cucina che reca a caratteri cubitali la scritta cuisine, tanto per non sbagliarsi.
Tutto è noia per Cheyenne, che è caratterizzato, oltre al trucco-parrucco da rock star dura, di quelle che ‘spaccano’, da una vocina infantile dalla cadenza perennemente strascicata, e dal fatto di non riuscire a fare più di un metro senza doversi sorreggere a qualcosa, che sia il carrello della spesa o il manico della valigia.

Cheyenne è, insomma, la personificazione della monotonia. Una monotonia che fa terribilmente a pugni col suo aspetto da anticonformista, di quelli che vivono sempre sopra le righe. Un aspetto che lo tiene ancorato, nonostante il passare degli anni, ai tempi della gioventù. O meglio, dell’adolescenza, quando il suo modo di apparire aveva un solo significato: ribellione. Ora però Cheyenne è quanto di più lontano possa esistere da un ribelle: è un marito innamorato e fedele da oltre trent’anni, e da venti non prende più in mano uno strumento musicale, trascinandosi in giorni di tedio che lui scambia per disagio esistenziale, convincendosi di essere afflitto da una seria forma di depressione.

In realtà, quello che manca a Cheyenne, è una ragione per crescere. Perché lui, questa cosa del crescere, non l’ha mai affrontata, come confermano le sue unghie laccate di nero e il pesante strato di matita che ogni mattina, diligentemente, applica alle palpebre ormai cascanti da cinquantenne. Conciato in questa maniera spaventa le clienti del supermercato in cui ogni mattina si reca a fare la spesa, salvo poi vendicarsi bucando loro il cartone del latte, esattamente come farebbe un bambino.
La notizia della morte improvvisa del padre, a New York, cambierà le carte in tavola e per Cheyenne arriverà finalmente il momento di prendere in mano il proprio destino.
Giunto sul posto, infatti, l’ex Rock Star viene a sapere che il padre, per tutta la vita, aveva invano dato la caccia ad un tedesco che era stato il suo aguzzino nel campo di concentramento di Auschwitz, e , incomprensibilmente, vista la sua verve e le sue pressoché nulle capacità investigative, Cheyenne decide di portare a termine la missione.

Il viaggio che compirà lungo gli Stati Uniti sulle tracce di quest’uomo acquisirà valenza di viaggio interiore, per Cheyenne. Un modo per confrontarsi con realtà diverse, per affrontare i demoni del passato, per riconciliarsi con la memoria del padre, un padre che lui ha sempre creduto, a torto, incapace di provare dell’affetto per il proprio figlio.
E sarà costretto a crescere.
L’uomo che farà ritorno a Dublino, dopo questa traversata, sarà un vero uomo.
L’uomo che per anni si è rifugiato dietro la maschera del personaggio, crogiolandosi nella paura di crescere e affrontare la realtà.
Perché la vita vera è fatta di questo: di persone che affrontano la realtà, per quanto dura o dolorosa possa essere.
Di persone che arrivate ad un certo punto, lasciano andare il cordone di sicurezza (o il manico della valigia) e camminano da sole, a viso aperto.
Senza trucchi, senza inganni, maschere, ceroni e chi più ne ha più ne metta.
Perché bisogna crescere e andare avanti.
Questo è vivere.
Ho trovato questo film di una bellezza e di una poesia incredibili, e credo di non esagerare se dico che è veramente il film più bello visto da molti mesi a questa parte.
La storia, nella sua semplicità, è capace di toccare corde profonde e ti resta impressa dentro, affrontando tematiche diverse quali l’olocausto, il rapporto padre-figlio, il bisogno che abbiamo tutti di avere una ragione per cui vivere, qualcosa che ci spinga avanti.
Simpatizzare col personaggio di Cheyenne, poi, è cosa immediata: per quanto strampalato e lontano da ognuno di noi possa apparire, in realtà è un personaggio incredibilmente umano, che dispensa vere e proprie perle di saggezza nell’arco dell’intero film. Dei bambini ha conservato l’aspetto più limpido e pulito, quello stupore che gli permette di guardare ancora il mondo con incredulità e meraviglia, nonostante le disillusioni e gli errori accumulati negli anni.

Nel panorama del cinema italiano avevamo bisogno di un film così. Un film che si discostasse dalle commedie-pattumiera, dai cinepanettoni e i film comico-demeziali che ci travolgono a vagonate ogni benedetto anno.
Un film dalla regia brillante, fatta di dettagli suggestivi (il filo del telefono che si tende, la sigaretta che si consuma tra le dita, i primissimi piani sugli sguardi), di inquadrature mozzafiato sugli incredibili paesaggi USA, con una stupenda colonna sonora e sì, fatta anche di bravi attori, Sean Penn su tutti, che da solo regge praticamente tutto il film.

I difetti, naturalmente, non mancano. Alcune sequenze sono effettivamente troppo lunghe (penso alla scena in cui David Byrne canta, appunto, This Must Be The Place) o slegate tra di loro, rendendo la narrazione poco omogenea in alcuni punti.
Ma sono convinta che un film, prima di tutto, vada visto ‘di pancia’.
E Cheyenne, nella sua lentezza, nella sua iniziale incapacità di evolversi, staccandosi da un passato che non gli appartiene più, nelle sue peripezie, a tratti quasi oniriche (penso alla scena dell’indiano nel pickup), a tratti decisamente comiche, nelle sue mille espressioni, che poi in realtà è sempre la stessa, è bellissimo.
E questo film sa davvero emozionare, perché è intriso di umanità.